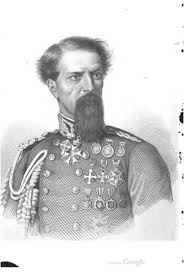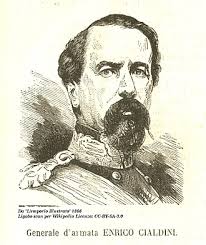![]()
Se l’Italia volesse cominciare a fare i conti con la propria storia, il 14 di agosto dovrebbe essere proclamato “giorno della verità” sul Risorgimento. Perché il paese di Pontelandolfo, in Campania, contava, quel 14 agosto 1861, quasi 4.500 abitanti. E dopo quel maledetto giorno purtroppo le cose cambiarono .
Erano infatti solo passati 7 giorni da quel 7 agosto del 1861 , quando un gruppo di ” briganti “capitanati dall’ex capitano borbonico Cosimo Giordano, forse animati dalla falsa notizia di uno sbarco dei Borboni , s’impadroniscono dei comuni di Casalduni e Pontelandolfo, nel Beneventano, uccidendo quattro “galantuomini” favorevoli al governo di Torino e cinque carabinieri. L’11 agosto i bersaglieri tentano di riprendere il controllo di Pontelandolfo: ma cadono in un’imboscata, e quaranta di loro furono purtroppo condotti a Casalduni e uccisi.
Ovviamente la reazione e la conseguente represione fu durissima . Su ordine del generale Enrico Cialdini , una colonna di cinquecento bersaglieri al comando del colonnello Pier Eleonoro Negri entrò all’alba del 14 agosto a Casalduni, dove trovarono poche persone: molti, avvisati per tempo dell’arrivo dei soldati erano fuggiti.
Ma purtroppo le cose per il comune di Pontelandolfo, andarono peggio in quanto gli abitanti furono in gran parte sorpresi nel sonno.
Su di loro piombarono come belve 500 bersaglieri del neonato Regno d’Italia, comandati dal colonnello, conte Pier Eleonoro Negri su ordine del generale Enrico Cialdini .
E fu l’inizio di una strage….
I bersaglieri entrati in paese, fucilarono quanti incontravano, entrarono nelle case, le saccheggiarono, massacrarono gli uomini, violentarono e uccisero donne e bambini. Appiccarono il fuoco alle case, e giocarono al tiro a segno con i disgraziati che fuggivano dalle abitazioni in fiamme, o li costrinsero a colpi di baionetta a tornare dentro per morire bruciati vivi. Centinaia e centinaia di cadaveri, bagnavano le strade di sangue : almeno 400 furono i morti, alcuni storici parlano di mille.
Perfino sui parroci e sui preti i bersaglieri del Regio Esercito italiano si accanirono, e con furia particolare, perché avevano benedetto le bandiere borboniche degli insorti.
E infine, sulle ceneri di quella barbarie, la propaganda sabauda stese la versione ufficiale, che parlava di uno “scontro con i briganti” gloriosamente vinto dal Regio Esercito, e di appena 14 vittime tra i civili.
Una versione dei fatti accaduti in quei comuni del Beneventano, che una storiografia obiettiva e onesta, sulla spinta di condizionamenti politici contigenti non ha mai voluto per decenni approfondire.
Purtroppo per oltre un secolo, la strage di Pontelandolfo è stata volutamente seppellita dalla propaganda italo-unitaria che aveva necessità di creare un’epica risorgimentale, fatta spesso anche con invenzioni, di cui andare fieri e con cui giustificare la conquista e la successiva annessione del Mezzogiorno Con questo intento, si fece di ogni erba un fascio trasformando in eroi decine di protagonisti di quegli anni.
Il colonnello conte Pier Eleonoro Negri, è ancora oggi considerato un protagonista del cosiddetto Risorgimento, e celebrato come un fulgido esempio di patriota italiano, al quale sono tuttora intitolate vie, strade in tuta Italia ( a Vicenza c’è anche una lapide che ricorda il grand’uomo). A lui sono state date tre medaglie al valor militare, nonché decorazioni al merito concesse da re Vittorio Emanuele II per l’eroico comportamento nelle battaglie risorgimentali, quando guidò lo sterminio di Pontelandolfo.

Ma il signor Negri non è l’unico eroe al quale sono state dedicata in tutta Italia, strade e piazze dopo il risorgimento e l’annessione del regno di Napoli a quello piemontese. Anche quel pezzo di cacca del generale Cialdini, utilzzando i poteri speciali che gli aveva concesso il nuovo re d’Italia Vittorio Emanuele II , ancora oggi vede il suo nome su epigrafi ,statue , piazze e strade .
Addirittura a Napoli, per quasi un secolo e mezzo, insieme al busto di Camillo Benso conte di Cavour, ha dominato con il suo busto di marmo, il salone delle grida nella sede della Camera di Commercio di Napoli in piazza della Borsa.
Il generale Cialdini ebbe dal primo re d’Italia il compito di spegnere a qualsiasi costo i focolai di resistenza borbonica nel Sud e lui lo fece alla grande , Fu lui infatti lui ad ordinare che di “Pontelandolfo non rimanesse pietra su pietra” , come diritto di rappresaglia in una guerra-non guerra civile. Fu proprio questo “criminale di guerra” che a capo di un nutrito corpo d’armata, forte di 22mila prima e 50mila uomini poi fino ad arrivare all’impiego di quasi 150mila soldati, represse i moti legati alla reazione di un Sud fedele tramite i suoi cosiddetti “briganti ” alla causa di Francesco II di Borbone con l’appoggio dello Stato Vaticano.
E’ sul suo capo infatti che pende l’accusa di essere stato il “massacratore” dell ’eccidio di Pontelandolfo, avvenuto nell’agosto del 1861 in cui, secondo le più recenti ricerche di stampo “revisionista”, persero la vita tra i 100 e i mille “cafoni”, contadini passati per le armi perché accusati di connivenza coi briganti e coi borbonici
La strage di Pontelandolfo fu una vera e propria rappresaglia del nuovo esercito italiano, del tutto analoga alle rappresaglie naziste contro i civili, dopo le azioni dei partigiani. Se l’avessero compiuta i nazisti, quella strage, nel paese martire ci sarebbero da decenni celebrazioni solenni, discorsi ufficiali delle massime autorità dello Stato, corone di fiori deposte da corazzieri in alta uniforme, e il colonnello veneto che comandò la strage sarebbe comunemente definito “boia di Pontelandolfo“.
La cosa ancor più grave è quella che a questo signore venne concesso il 5 marzo del 1861, addirittura la cittadinanza onoraria della nostra città. Una strana decisione se solo pensiamo che il generale Cialdini è stato uno tra i conquistatori della sconfitta Nazione napoletana.Egli infatti aveva bombardato Gaeta senza scrupoli, anche se sotto i colpi dei cannoni a lunga gittata piemontesi morivano anche i civili che non avevano voluto abbandonare il Borgo
N.B. In realtà vennero concesse anche altre due cittadinanze onorarie : la prima a Giuseppe Garibaldi (18 settembre 1860) , e la seconda a Salvatore Pes marchese di Villamarina (2 novembre 1860), che era stato ambasciatore del Piemonte a Napoli,
Nella nostra città in verità si fece molto di più. Con una vera e propria mossa politica altamente stategica venne operata una vera e propria “cancellazione della memoria” di determinati eventi storici e la contemporanea la distruzione di qualsiasi traccia che potesse tramandarla ai posteri, come se non fosse mai esistita.
Venne praticamente realizzato un progetto tendente a cancellare la memoria storica della dinastia Borbonica cambiando i nomi alla strade o a alle piazze che in qualche modo potessero rappresentare un simbolo della vecchia monarchia.
Gli antichi latini avrebbero parlato di Damnatio memoriae,
La rimozione delle memoria di quanto c’era stato anche di positivo nel passato, accompagnata dal furore ideologico che accompagna ogni avvicendamento di potere, innalzò miti, esaltò personaggi che in fretta avevano sostituito quelli che avevano guidato la nazione napoletana fino a poche settimane prima.
Molte strade e Piazze da quel momento hanno perso la loro vera identità e storia spesso sostituiti da quelli dei principi piemontesi.
Un esempio su tutti è il nome del Corso Vittorio Emanuele. Tale nome oggi non ci parla né dei creatori né delle finalità del percorso.
La strada nessuno oggi lo ricorda ma esse fu voluta da Ferdinando II, ed è stata il primo esempio di tangenziale in Europa, con lo scopo di collegare due nuclei estremi della città dell’epoca: Chiaia e Capodimonte ( collegando quindi anche la città bassa con il Vomero).
Una strada che invece di passare in basso, tra le case, tagliava la collina, snellendo il traffico delle carrozze e delle merci.
Nessuno ancora oggi sa che originariamente la strada si chiamava «Corso Maria Teresa», in onore di Maria Teresa d’Asburgo Lorena, seconda moglie di re Ferdinando II che commissionò, nel 1853, il progetto all’architetto Errico Alvino (la prima era stata Maria Cristina di Savoia).
L’opera venne realizzata nel pieno rispetto del paesaggio poichè il sovrano decise di tutelare l’area con un editto che vietava ogni costruzione verso il mare ( quindi sul lato sinistro della strada ) imponendo il rispetto del panorama; questa restrizione riguardava già dal 1841 le zone di Capodimonte, Mergellina Posillipo e Coroglio e fu quindi estesa anche al corso Maria Teresa.
Dopo la conquista garibaldina e l’annessione al regno del Piemonte il nome venne cambiato in corso Vittorio Emanuele (sigh!)
Vittorio Emanuele III, ebbe addirittura la bellezza di quattro strade dedicate al suo nome.
Dal 1861, esempi di piazze o strade con nomi piemontesi le poete trovare ovunque così come le piazze o le vie dedicate a Garibaldi e Cavour, e quelle intitolate a Roma capitale.
A Cavour è infatti intitolata una piazza (ex Largo delle pigne) nella strada più borbonica di Napoli: via Foria (acronimo di «Fora ’a via»).
Nello slargo di Via Toledo prima denominato ” largo dello Spirito Santo“. per la presenza della vicina chiesa , dopo l’unitò d’Italia esso cambio nome in Piazza Sette Settembre,in onore alla data in cui il generale Giuseppe Garibaldi ( il 7 settembre 1860 ) fece il suo ingresso nella città partenopea e una volta alloggiato in Palazzo Doria D’Angri, proclamò dal balcone del palazzo che affaccia su Largo dello Spirito Santo l’annessione delle province meridionali al Regno sabaudo.
Piazza Dante, uno slargo voluto da Carlo di Borbone denominata fino al 1871 Foro Carolino, in onore proprio del Re, venne poi denominato dopo l’unità d’Italia con il nome del sommo poeta grazie alla realizzazione di una statua di Dante posta nella piazza sul cui basamento è inciso «All’unità d’Italia raffigurata in Dante Alighieri», solo perché egli parlò nei suoi scritti dell’Unita d’Italia, ma in realtà è situata in quel posto per azzerare il vecchio nome e far sloggiare la statua del sovrano precedentemente presente.
Piazza Trieste e Trento oggi non si chiama più Piazza San Ferdinando come quando fino al 1919 era era presente il busto del re borbonico Ferdinando II, che fu ovviamente rimosso dai piemontesi e accantonato in deposito di Pietrarsa.
La vicina galleria è ovviamente dedicata ad uno di loro ed infatti si chiama Galleria Umberto I ma anche l’altra galleria al Museo si chiama Galleria del Principe…
Anche la piazza più grande della città non è ovviamente sfuggìta a tal destino. La piazza del Plebiscito, ex Largo di palazzo, era il luogo dove si riunivano le truppe in parata per salutare il re e prende l’attuale nome dal plebiscito popolare del 1860 dichiarato da molti come falso, con cui Napoli diceva sì all’annessione al Regno dei Savoia.
Per non parlare poi di Corso Garibaldi e Piazza Garibaldi , primo punto di entrata in città per chi viene da fuori , che prima si chiamava Piazza della Stazione o della Ferrovia, in ricordo del fatto che la prima ferrovia d’Italia fu creata dai Borbone.
Oggi fortunatamente lo cose anche se lentamente stanno cambiando grazie alla rilettura, gli studi e gli approfondimenti, anche controversi, sul Risorgimento e l’annessione delle ex Due Sicilie.
E da anni, grazie anche alla forte voce di nuove e più presenti associazioni borboniche che sulla spinta di una nuova voglia di conoscere meglio la propria storia, si rileggono e si rivedono sotto una luce diversa quei fatti storici con quella serenità di chi con orgoglio e identità meridionale, vuole approfondire studi e idee talvolta anche controverse, sul Risorgimento e l’annessione delle ex Due Sicilie. La storia, in fondo, sulla scia di documenti e studi sempre diversi e con differenti sensibilità e conoscenze, deve essere anche revisionismo del revisionismo capace di dare più attenzione ai personaggi locali, agli eroi scordati, alle figure cadute nel dimenticatoio dove giacciono tutti i vinti della storia stessa.
La revoca della cittadinanza a Cialdini, decisa dall’amministrazione comunale nell’aprile del 2017, e la decisione della giunta della Camera di Commercio di rimuovere il busto dalla sede di piazza della Borsa sono testimonianze di un nuovo approccio verso gli avvenimenti del 1861.
Tutto questo mostra e testimonia, una volta di più, la forte volontà del Sud di riprendersi un’identità forte rielaborando fonti e ritratti storici che non hano n salvato dalla sua scure nemmeno i personaggi che parevano intoccabili, su tutti Giuseppe Garibaldi.
Oggi la verità sulla strage di Pontelandolfo la sappiamo dalle ceneri di centinaia di abitazioni, dallo sdegno e dal pianto di chi le vide, da scampoli di antiche, coraggiose interrogazioni parlamentari dell’epoca cadute nel silenzio, e sopratutto dalla scoperta di una fossa comune con i cadaveri di oltre duecento persone,
Ma sopratutto è dalla penna di un bersagliere, tale Carlo Margolfo, di Sondrio, che anni dopo scrisse le sue memorie, forse se per togliersi dalla coscienza il peso terribile di quella strage. “Entrammo nel paese, subito cominciammo a fucilare preti e uomini, quanti capitava…“.
Oggi si sa che i morti furono almeno quattrocento, dieci per ogni bersagliere ucciso secondo la logica perversa che tutti condannano per le Fosse Ardeatine ma dimenticano quando si tratta del Risorgimento e del Sud. Ma c’è chi parla di mille, aggiungendo episodi successivi di repressione e coloro che morirono per le ferite patite il 14 agosto.
Ecco quanto scrisse il soldato, Carlo Margolfo, nelle sue memorie di quanto avvenne a Pontelandolfo, con parole che meritano di essere riportate per intero:
“Al mattino del giorno 14 (agosto) riceviamo l’ordine superiore di entrare a Pontelandolfo, fucilare gli abitanti, meno le donne e gli infermi (ma molte donne perirono) ed incendiarlo. Entrammo nel paese, subito abbiamo incominciato a fucilare i preti e gli uomini, quanti capitava; indi il soldato saccheggiava, ed infine ne abbiamo dato l’incendio al paese. Non si poteva stare d’intorno per il gran calore, e quale rumore facevano quei poveri diavoli cui la sorte era di morire abbrustoliti o sotto le rovine delle case. Noi invece durante l’incendio avevamo di tutto: pollastri, pane, vino e capponi, niente mancava…Casalduni fu l’obiettivo del maggiore Melegari. I pochi che erano rimasti si chiusero in casa, ed i bersaglieri corsero per vie e vicoli, sfondarono le porte. Chi usciva di casa veniva colpito con le baionette, chi scappava veniva preso a fucilate. Furono tre ore di fuoco, dalle case venivano portate fuori le cose migliori, i bersaglieri ne riempivano gli zaini, il fuoco crepitava”.
Ma il soldato Margolfo tace pudicamente gli stupri delle donne, che non risparmiarono né le anziane né giovani ragazze e la profanazione della Chiesa Madre, dove fu perfino strappata alla Madonna la sua corona, che risultano da altri resoconti e sono riassunti nella recente delibera comunale che ha proclamato Pontelandolfo “città martire”.
Oggi si sa che i morti furono almeno quattrocento, dieci per ogni bersagliere ucciso secondo la logica perversa che tutti condannano per le Fosse Ardeatine ma dimenticano quando si tratta del Risorgimento e del Sud. Ma c’è chi parla di mille, aggiungendo episodi successivi di repressione e coloro che morirono per le ferite patite il 14 agosto.
N.B.Lo storico Denis Mack Smith calcola che la guerra di conquista del Sud, paese per paese, sia costata almeno diecimila morti, quasi il doppio dei caduti in tutte le guerre cosiddette d’indipedenza contro l’Austria.
Eppure per oltre due secoli, la strage di Pontelandolfo fu seppellita dalla propaganda italo-unitaria.
Fino ad oggi, soltanto un presidente del Consiglio, Giuliano Amato, s’è fatto vedere in quei luoghi per chiedere scusa, e ancora oggi, storici italounitari diffondono la favoletta delle sole 14 vittime civili inventata 160 anni fa dalla propaganda sabauda.
«Lo Stato Italiano è stato una dittatura feroce che ha messo a ferro e fuoco l’Italia meridionale e le isole, squartando, fucilando, seppellendo vivi i contadini poveri che scrittori salariati tentarono di infamare col marchio di briganti». Così scrisse Antonio Gramsci, nel 1920.
E’ arrivato finalmente il giorno che di fronte a quanto accaduto a Pontelandolfo e di Casalduni, o negli altri paesi dati alle fiamme e saccheggiati nel nome dell’unità d’Italia – (Auletta, Venosa, Barile, Monteverde, San Marco, Rignano, Spinelli, Carbonara, Montefalcione, Basile, Cotronei… ) dovremmo avere il coraggio civile di non parlare più di Risorgimento, ma di feroce, spietata, sanguinaria conquista del Sud e di conquista dei legittimi antichi Stati della Penisola da parte dei Savoia, appoggiati dalla massoneria che aveva l’obiettivo di indebolire il potere dei Papi, togliendo loro lo Stato della Chiesa.
Dovremmo parlare di una guerra di conquista condotta usando le armi della propaganda,che spacciava per liberatore l’esercito invasore, e per briganti le genti che resistevano in difesa delle loro terre, fedeli al loro legittimo re.
Briganto poi deportati insieme ad altra centinaia di soldati borbonici nel forte piemontese di Fenestrelle per essere lasciati morire di stento e di freddi dopo di che, i loro corpi, troppo numerosi per essere sepolti, erano gettati in un pozzo di calce viva.