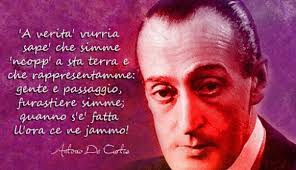![]()
Il rapporto speciale che i napoletani hanno con la morte non si limita come tutti pensano al solo culto delle anime pezzentelle tanto è vero che la famosa festa americana di Halloween a Napoli è sempre esistita. Essa è sopratutto una festa che era conosciuta a Napoli già nel dopoguerra, anche se allora non si festeggiava il 31 ottobre come avviene oggi, bensì nel giorno di Ognissanti, cioè il primo novembre.
All’epoca bambini e ragazzi si aggiravano mascherati per i quartieri popolari chiedendo dolci e caramelle, ma al posto del tipico “Dolcetto o scherzetto?”, accompagnati da strumenti musicali (spesso di fortuna) gridavano: “Cicci muorti”.
N.B. I “Cicci” altro non erano che i chicchi di grano. Questi venivano fatti bollire e poi ripassati nel miele e nello zucchero, creando di fatto un ottimo dolce, ma decisamente povero.
Inoltre, era usanza camminare per le strade della città con una cassetta di cartone a forma di bara, chiamato: “o tavutiello”. In essa venivano stipate le leccornie ricevute in dono, che potevano essere: caramelle, fichi secchi, uva passa, biscotti e ovviamente I cicci muorti.
Durante il loro cammino per attirare l’attenzione delle massaie non mancavano le invocazioni, che recitavano pressappoco così:”Famme bene pe’ li muorte: dint’a ‘sta péttula che ‘ce puórte? Passer e ficusecche ‘nce puórte? E famme bene pe’ li muorte”
Traduzione: “Fammi del bene per i morti: in questo grembiule che ci porti? Uva passa e fichi secchi porti? E fammi del bene per i morti.
A tal proposito la giornalista e scrittrice Matilde Serao nel 1904 sulla rivista “Il Giorno”ci parlava amche della “ccascettelle d”e muorte” e così scriveva :
“Domani mattina, a Dio piacendo, saremo svegliati da un’orchestrina originale di strumenti non molto melodiosi, ma per compenso sufficientemente assordanti. Centomila scatolette di cartone, debitamente segnate col teschio tradizionale e le immancabili ossa incrociate, faranno risuonare per tutte le vie di Napoli, per tutti i vicoli, per tutti i cortili, per i pianerottoli delle nostre scale, i soldini che vi sono piovuti dentro, attraverso la sottile fenditura, ed il rullo di questo strano tamburino ci accompagnerà da per tutto, e, dovunque, un bambino, due bambini, dieci bambini ci affronteranno, ci stringeranno in mezzo, ci sgusceranno tra i piedi, agitando la cascettella e strillando in tutti i toni: “Signurì, ‘e muorte!”.
I morti si celebrano quindi da sempre nella nostra città con i dolci, e questo perché il dolce ha per tradizione il compito di addolcire il viaggio verso l’aldilà, mitigando le ansie e i dolori del trapasso dei nostri cari dal mondo dell’aldiquà al mondo dell’aldilà. E i morti ringraziano quelli che sono rimasti sulla terra, per le cure che si prenderanno delle loro anime, anch’essi con dei dolcetti. Insomma uno scambio di cortesie. che ci tramandiamo da sempre ( fin dalle origini greche ) in quanto noi sappiamo che i Fin dalle nostre origini greche ci tramandiamo il culto del pianto durante i funerali, piangere fino a quando le salme non si distaccano totalmente da noi anche se sappiamo che i nostri nostri cari e le persone a cui più volgiamo bene , quando ci lasciano, non ci lasciano mai da soli, e siamo pronti accoglierli nel miglior modo possibile quando vengono a farci visita nella notte tra il 1 e il 2 novembre con l’usanza di imbandire la tavola e lasciare un posto vuoto riservato a loro.
N.B.Secondo una antica usanza, inoltre,salle nostre parti , la sera prima della festa di Ognissanti, si allestivano tavole imbandite per dare ristoro ai defunti che andavano in visita per le case.
Come quindi prima vi ho accennato una festa molto simile a quella americana di Halloween si festeggiava nella nostra città, non il 31 ottobre ma al primo giorno del mese di novembre novembre, dove come tutti sanno, per secoli come dolce nella nostra città per usanza si mangiava del torrono duro, quello di Montevergine per intenderci, proprio perché era ed è un dolce che si presta benissimo alla lunga conservazione.
CURIOSITA’: La parola torrone deriva dal latino torreo (abbrustolire) in quanto le nocciole del torrone vengono preliminarmente abbrustolite. Oppure potrebbe derivare dal latino tautanus (da cui tutero) ovvero clava, mazza.
Ma in una città come la nostra i cui abitanti dialogano con l’aldilà, che si fa dare i numeri in sogno dai parenti passati a miglior vita, che adotta le capuzzelle anonime e che manda refrischi all’anema ‘o priatorio, non ci meraviglia che ai poveri morti qualcuno ( magari in cambio di un devoto favore ) abbia pensato anche ai loro denti.
Le anime dei defunti sono infatti spesso anziane e non hanno i denti in grado di spezzare il durissimo torrone tradizionale. Bisognava quindi realizzare un torrone morbido, più adatto alla loro dentatura. E così il torrone dei morti non fu più una mazza tosta, ma divenne un dolce completamente diverso, morbido; il perfetto compagno di viaggio dell’anima che sale in cielo. Il nome rimase quello di “torrone” e le fette vennero dette “murticielli”.
Fette che hanno la forma trapezoidale perché devono ricordare la cassa da morto. Poi alcuni pasticcieri pensarono che la forma di cassa da morto portasse male, e allora si è fatto ricorso ad una forma di semicerchio. Ma sempre murticielli li chiamiamo!
Ma vi siete ma chiesto perché ci si scambiano dolci nel periodo di Ognissanti?
Secondo antiche tradizioni, la festa di Ognissanti era il giorno ideale per ricordarsi dei propri cari defunti. Essi a loro volta, secondo una vecchia credenza popolare, verrebbero in quel giorno, a trovarci nelle nostre case , e quindi occorre confortare e placare le loro anime con delle offerte che nella fattispecie vengono rappresentate da dolci come il torrone .
CURIOSITA’: Probabilmente questo modo di fare era semplicemente un modo per esorcizzare la paura dell’ignoto e della morte.
Ad ogni modo, resta il fatto che ad oggi in molte località della Campania ma soprattutto a Napoli, è presente la tradizione di preparare biscotti e torroni dalla vaga forma di ossa o addirittura con la forma di una cassa da morto .
Insomma … vuoi vedere che alla fine questa festa di Halloween tanto amata e celebrata in tutto il mondo, abbia le sue origini proprio nella nostra città ?
Le sue vere origini in verità sono moltopiù complesse e antiche di quanto si creda.
Nonostante questa festa sia spesso associata agli Stati Uniti, Halloween trova infatti le sue radici in Irlanda, dove nasce come la festività celtica di Samhain, che in celtico significa “fine dell’estate”. Samhain segnava la fine della stagione calda e l’inizio dell’autunno, momento in cui si credeva che, nella notte del 31 ottobre, gli spiriti dei defunti potessero tornare sulla terra. Per proteggersi da queste presenze, le persone intagliavano rape, creando lanterne spettrali, e si mascheravano per non essere riconosciuti dai morti.
Con il passare del tempo, alla celebrazione di Samhain si è unita un’altra leggenda: quella di Jack-o’-Lantern, un fabbro astuto che, ingannando il diavolo, ottenne la promessa che la sua anima non sarebbe mai stata reclamata. Tuttavia, a causa della sua vita sregolata, alla morte Jack non fu accolto né in paradiso né all’inferno, e fu condannato a vagare per l’eternità con una lanterna ricavata da una rapa per illuminare il suo cammino.
Questo simbolo della rapa rimase tale fino a quando, durante la grande carestia dell’800, molte famiglie irlandesi emigrarono in America, trovando più facile reperire zucche da intagliare, che diventarono così l’emblema di Halloween.
N.B. Anche quella antica tradizioni popolari che considera la zucca un contenitore soprannaturale delle anime dei defunti trova in un certo senso una sua origine dalle nostre parti e con precisione a Somma Vesuciana dove negli ambienti contadini tagliare zucche e riempirle con le luci era largamente diffuso , In questa località infatti si organizzava la Festa delle Lucerne in cui i morti si manifestavano sotto forma di teste di zucca che brillavano nelle tenebre.
Di questa antica credenza, com’è noto, Halloween è la massima espressione. Zucche da mille forme e colori vengono intagliate da grandi e piccini in smorfie paurose e di terrore.
La tradizione del “dolcetto o scherzetto” invece si sviluppò più tardi, frutto di una mescolanza culturale tra le usanze europee e nordamericane, e nella nostra città raggiunse subito un aspetto giocose e festoso sopratutto tra i giovani scugnizzi napoletani che nel nome dei morti , nella notte del 31 ottobre , approfittavano dell’evento per chiedere un’offerta di confetti e soldini agitando le loro cascetelle,
Era praticamente la stessa cosa della nota festa che accade di questi tempi la sera di Halloween, quando una un mare di bambini sciamando in tutta la città bussa alla porta dei napoletani minacciando “dolcetto o scherzetto”, solo che all’epoca i scugnizzi si aggiravano per le strade con in mano “o tavutiello”, (cassetta di cartone a forma di bara), pronunciando l’ invocazione “Cicci muorti!”.
Come i bambini partenopei festeggiavano i morti ci viene anche narrato in maniera sublime in una bella poesia napoletana del 1875 :
Chi vò accattarese na cascettella, pe sta a arrecogliere la mmarennella?
Nce staje ccà a spennere no tornesiello, Sta a contentarese lo guaglìonciello!
Cheste le ffraveca Ciccella mia, pe starle a ‘bbennere mmiezo a la via!
Co ccarte scevote da le quaranta, cheste t’azzeccano chi se nne vanta!..
Nc’è l’asso, crideme, Nce sta no Rre, Sett’oro, ed autra Carta ccà nc’è!..
Ncoppa se spaccano pe le ggranelle, addo s’accostano Mane e mmanelle!..
E fanno sentere Pò lo rommore, chille che frisole danno de core!
E tutte diceno: Li muorte! Li muorte! Sotto a la pettola ‘cca che nce puorte
E tutte a smestere stanno lli ggente, lo ricco suggeco co lo pezzente!
E ognuno jenghere sta cascia fà! De rane e prubbeche senza contà!
E quann’è a ll’urdemo Ste ccascetlelle tutte te stracciano ninne e nennelle!
Zzò ch’arrecoglieno stanno a mmagnarse, torrune ed autro poje p’accattarse!
E piezze fauze stanno a trovare, de chi, pe rridere, L’è state a ddare!..
Sà comme ròseca lo guaglionciello !.. Non lo ‘bbo credere lo poveriello!..
Ma, tutto è ‘nnutele, Accussì bbà, Sempe no truvolo ‘nce àve da stà!.
Delle cascettelle parla anche Eduardo De Flippo in Filumena Marturano: “…ambo due e con tre figli da crescere, andai ad abitare al vicolo San Liborio, basso numero 80, e mi misi a vendere sciosciamosche, cascettelle p’’e muorte e cappielle ‘e Piererotta”.
Se quindi qualcuno di voi pensa , che l’usanza di chiedere i dolci il giorno di Halloween sia una contaminazione americana che si è diffusa nella nostra città , si sbaglia di grosso. Da sempre a Napoli durante la celebrazione della festa dei morti ci si scambiano dolci, per simboleggiare i doni che i defunti portano dal cielo e contemporaneamente l’offerta di ristoro dei vivi per il loro viaggio.Era infatti anche questo un modo per esorcizzare la paura dell’ignoto e della morte, .
In particolare, a Napoli si consumava in questa cicostanza il torrone e non uno qualsiasi: in origine il Murticiello o Morticino era un bianco, a base di cioccolato e trapezoidale a forma di bara. Il dolce, inoltre, era molto soffice affinché il morto, ormai senza denti, potesse mangiarlo in tranquillità. Così i napoletani cercavano di addolcire il viaggio del morto verso l’aldilà. Per scaramanzia, come sempre a Napoli, i pasticceri decisero di cambiare la forma del torrone passando da quella trapezoidale a una semisferica.
Insomma , quando la sera di Halloween quei bambini vestiti da personaggi magici e misteriosi come Streghe, maghi, vampiri, scheletri e zucche, busseranno alla vostra porta per chiedervi un dolcino o delle caramelle , ricordatevi che non si tratta della solita americanata.
O meglio …lo è senz’altro, in quanto gli americani hanno come sempre sicuramente spettacolarizzato tutto , ma questa festa ha sopratutto antiche origini nella nostra città.
L’Halloween partenopeo , le anime pezzentelle ,’e cap e mort , il cimitero delle fontanelle, i santoni, gli assistiti, A refrische, a preghiera ‘e ll’anime d’o priatorio”.sono in fondo solo solo parte di quella consapevolezza dei napoletani che nel loro speciale rapporto con la morte hanno capito che in fondo “all’ àutro munno simm tutte eguale” e “Simm tutt cape ‘e morte”, cioè che “la morte è la completa uguaglianza degli ineguali”, è “una livella” a detta di Totò: ciò che era visibile e rilevante in vita diviene invisibile ed irrilevante nella dimensione sospesa (“queste pagliacciate le fanno solo i vivi: noi siamo seri…apparteniamo alla morte”, proclama l’ombra del netturbino a quella del marchese che disdegnava di essere sepolto accanto a lui.