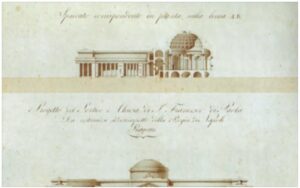![]()
 La Basilica di San Francesco di Paola si trova nella piazza più grande della città, ovvero in Piazza Plebiscito.
La Basilica di San Francesco di Paola si trova nella piazza più grande della città, ovvero in Piazza Plebiscito.
La Storia di questa basilica comincia nel 1809, quando Gioacchino Murat, durante il cosiddetto “decennio Francese”, decide di demolire i conventi di “Largo di Palazzo” (l’attuale Piazza del Plebiscito) dedicati a San Francesco di Paola per ampliare la piazza e trasformarla nel principale foro cittadino affidandone i lavori all’architetto Leopoldo Laperuta che, proprio di fronte al Palazzo Reale, costruì un grande emiciclo con un ampio portico sorretto da 38 colonne doriche.
Il progetto prevedeva un vero e proprio FORO da chiamarsi ” FORO MURAT ” ma questo non pote’ essere completato e quando egli alla fine del suo regno fu processato, condannato e giustiziato (fucilato) a Pizzo Calabro la sera del 13 ottobre 1815, era stato solo finito il porticato.
Nel 1815, Re Ferdinando I, una volta restaurata la supremazia dei Borboni, grazie al declino di Napoleone ed il conseguente congresso di Vienna, volle edificare una basilica da dedicare a San Francesco da Paola, come ringraziamento per l’avvenuta riconquista del regno e come risarcimento per la distruzione degli antichi conventi.
Ferdinando rientrato a Napoli dal suo ritorno da Palermo, pensò bene di sfruttare l’opera del suo predecessore e volle che nel centro del portico sorgesse la chiesa che aveva promesso in voto se avesse riavuto il trono. Nacque così la chiesa di San Francesco di Paola. Egli incaricò l’architetto Pietro Bianchi di Lugano (uno dei migliori artisti del’epoca della scuola neoclassica), di erigere l’attuale Basilica sull’antica area della vecchia chiesa di San Luigi di Palazzo e decise di chiamarla in questo modo in onore di San Francesco di Paola. Lo stesso emiciclo della chiesa fu ulteriormente abbellito realizzando dallo stesso Bianchi otto statue di leoni egizi.
I lavori della Basilica durarono circa 30 anni, e furono terminati dagli allievi del Bianchi, nel 1846.
San Francesco aveva vissuto a Napoli molto tempo prima. Egli abitava a Paola (un piccolo centro della Calabria) ,e fu invitato a Napoli nel 1481 da re Ferrante I D’Aragona su insistenza del re di Francia Luigi XI, al quale erano giunte numerose voci sulla santità del Monaco. Il pio religioso Francesco fu ricevuto con grandi onori dal re e scelse di abitare e vivere in una stanzetta ancora oggi esistente nella Reggia di Castelnuovo. Durante questa dimora il Re lo pregò di fondare un convento in Napoli. Il Santo scelse un luogo solitario e allora malfamato sovrastante il mare, sulle pendici settentrionali del monte Echia (odierna zona di Monte di Dio).
Il frate durante i lavori di costruzione del convento profetizzò anche che quel luogo sarebbe divenuto in breve il centro più importante e popolato non solo di tutta Napoli ma del Regno intero. Ultimato il convento fu costruito accanto ad esso anche una Chiesa dedicata a S. Luigi per la presenza di una Cappella allora esistente e dedicata a questo Santo.
Durante i lavori pervennero molte elemosine ed una cospicua elargizione da parte del Re. Si dice che il Santo respingesse le molte monete d’oro affermando che egli gradiva le elemosine fatte con danaro proprio e non col sangue della povera gente. Il Re, stupito da tale affermazione, volle saperne la ragione, ed il Santo divise in due una moneta d’oro facendone uscire del sangue vivo. Questo episodio è rappresentato in un quadro esistente nella Chiesa di S. Sebastiano Martire nel Maschio Angioino.
Si entra nella chiesa da un ampio pronao formato da sei colonne in stile ionico e due pilastri ,sul quale è possibile leggere la dedica al santo. Le colonne sorreggono un timpano triangolare sulla cui sommità è posta la statua della Religione. All’estremità destra è posta la scultura di San Ferdinando di Castiglia, a sinistra quella di San Francesco di Paola.
Nel porticato sottostante, invece troviamo le statue delle quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza e temperanza) e le tre virtù teologali (fede, speranza e carità). A completare l’esterno ci sono tre belle cupole di cui quella centrale che poggia su un ampio tamburo è alta 53 metri.
Nella piazza si decise poi di costruire nel 1829 le due statue equestri ancora oggi presenti, in onore di re Ferdinando e del padre Carlo III di Spagna; la prima opera di Antonio Canova e la seconda di Antonio Calì.
L’interno è preceduto da un atrio con due Cappelloni: uno per il Sacramento, a destra; l’altro, a sinistra, dedicato alle Anime del Purgatorio. La Basilica, che si ispira al Pantheon di Agrippa in Roma consta di una semisfera poggiata su di un cilindro che dà luogo ad una rotonda centrale larga 34 metri ed alta 53.
Superato l’atrio si accede al corpo centrale della chiesa, dalla forma rotonda (a pianta circolare) con un diametro di trentaquattro metri interamente pavimentato con marmi policromi a riprodurre disegni geometrici .
Entrando nello spazio della basilica subito notiamo che la rotonda centrale è circondata da un colonnato corinzio continuo di trentadue colonne di marmo di Mondragone che sorreggono una imponente cupola centrale, decorata con lacunari e rosoni di pietra calcarea.
Le 32 colonne di stile corinzio che sostengono la Cupola e formano la base del cilindro( la rotonda centrale ) sono alte 11 metri, tra otto pilastri di eguale altezza ordinati in eguale distanza da formare in giro le sei cappelle e le otto nicchie con otto statue di marmo.
La chiesa è abbellita e arricchita da numerose sculture e pitture del 1800.
Appena entrati ci si trova in un atrio dal quale si può accedere a due cappelle laterali; in quella destra l’ambiente è arricchito da pitture di artisti neoclassici napoletani conservati come una grande tela che raffigura San Giovanni Battista nel deserto di Antonio Licata, il Cristo e deposizione nel sepolcro di Tommaso De Vivo e Le tre Marie al sepolcro di Giuseppe Bonito, proveniente da una delle due chiese demolite.
La cappella di sinistra invece custodisce una tela di un giovane Luca Giordano raffigurante Sant’Onofrio eremita, un’Adorazione dei Magi di Raffaele Postiglione, e una bella tela raffigurante il Battesimo di Cristo di Paolo De Matteis.
Lungo il perimetro si intravedono sei cappelle laterali. Tra le cappelle poggiate su piedistalli ci sono otto sculture di santi .
Sia sulla parte sinistra che su quella destra si aprono tre cappelle: a sinistra queste sono adornate con tele di Tommaso De Vivo (ritraenti una la Morte di sant’Andrea Avellino, e l’ altra l’Immacolata), e un’opera di Camillo Guerra con il Transito di san Giuseppe, , mentre in quella di destra possiamo ammirare un’opera di Nicola Carta ( San Nicola e San Francesco di Paola che riceve lo stemma della carità da un angelo), una di Pietro Benvenuti (l’Ultima Comunione di San Ferdinando di Castiglia).
Di fronte l’ingresso troviamo l’abside con il prezioso altare principale, ricco di pietre preziose disegnato nel 1751 da Ferdinando Fuga, e trasferito in questo luogo dalla iniziale sede della chiesa dei Santi Apostoli nel 1835. Ai suoi lati sono poste due colonne in breccia egiziaca utilizzate come candelabri ( provenienti dalla chiesa dei Santi Severino e Sossio) e due Angeli in cartapesta dorata. Sulla parete è conservata la tela raffigurante San Francesco di Paola che resuscita un morto di Vincenzo Camuccini, realizzata su diretto incarico di Francesco I di Borbone.
Nel presbiterio della cappella, sulla sinistra, si vede il Martirio di Sant’Irene del senese Francesco Nenci e a destra Cristo che scaccia Satana di A. De Crescenzo. Il dipinto di San Francesco di Paola forse è una copia di un’opera non identificata di Ribera. Il tabernacolo ha la stessa provenienza dell’altare ed è opera di Francesco Grimaldi.
Nella sagrestia ci sono dipinti di altre chiese e della Cappella di Santa Barbara in Castel Nuovo. Degno di nota il busto in stucco dorato di San Francesco di Paola databile al Settecento e due opere : una di Gaspare Landi ( l’ Immacolata ) ed un’altra di Antonio Campi ( la circoncisione ).
Nella prima nicchia a destra vi è un quadro copiato da un originale di Van Dyck raffigurante Cristo Crocifisso, eseguito da Tommaso De Vivo, che è anche l’autore della tela posta sull’altare adiacente con la Deposizione di Cristo nel Sepolcro, copiato da una famosa opera di Caravaggio.
Il pavimento, dal complesso disegno geometrico, come già detto, fu ideato da Pietro Bianchi con l’utilizzo di vari marmi.
N.B. Al di sotto della Basilica è ancora oggi presente presente un vasto complesso sotterraneo risalente al progetto ottocentesco di Gioacchino Murat per la sistemazione di Piazza del Plebiscito.
Realizzato in pietra di tufo con coperture a volta, questo enorme spazio sotteraneo , posto a 6 metri sotto il vestibolo della chiesa è caratterizzato da una grande sala circolare centrale che riprende le dimensioni della navata superiore e da una rete di cunicoli e corridoi con un’imponente struttura a fungo al centro che riecheggia la pianta della chiesa superiore.
Tale ipogeo costituito da una volta centrale sorretta da una struttura a fungo, ha un’altezza variabile dai 4,00 m ai 5,60 m.
Dalla sala centrale, spazialmente definita da un pilastro ad archi a forma di fungo, attraverso un sistema di percorsi concentrici e di cunicoli è possibile raggiungere quattro sale più piccole, una di forma ottagonale, due circolari e una poligonale, poste a quote differenti ma corrispondenti anch’esse alle sovrastanti cappelle della chiesa.
N.B. Questo genere di struttura ipogea non è estraneo al complesso e diffuso sistema di “città sotterranea” che caratterizza Napoli e che fu realizzato attraverso scavi effettuati fin dall’epoca greco-romana all’interno dei numerosi costoni tufacei, generatisi dall’aggregazione dei detriti vulcanici accumulatisi in seguito alla remota attività eruttiva dei Campi Flegrei. Un mondo ”di sotto” che ha permesso a quello superiore di esistere grazie ai materiali che ne vennero cavati nel corso dei secoli.
L’accesso all’ipogeo è garantito in maniera autonoma da un ingresso che si trova all’interno dei locali corrispondenti ai civici 6 e 7 del colonnato.
CURIOSITA’ : L’ipogeo ampio più di 1000 metri quadri e con un’altezza in alcuni punti anche di circa 16 metri ha una capacità di ospitare fino a 300 persone alla volta . Esso è stato finalmente liberato dai detriti nel 2018 ed è in corso da allora un progetto di di riqualificazione per essere aperto al pubblico. L’obiettivo è trasformarlo in un museo permanente e in un luogo per attività culturali, artistiche e museali, con un’attenzione a tecnologie innovative. Secondo questo progetto il pubblico potrà accedere attraverso una scala e un ascensore in vetro, immergendosi nel ventre della città fra archi e pietre di tufo lasciati a vista e tracce dei palazzi ottocenteschi a suo tempo abbattuti per lasciare spazio alla nuova struttura.
Ora sono convinto che molti di voi certamente state pensando che questo enorme spazio sia solo frutto delle antiche fondamenta delle due chiese, ma vi voglio subito ammonire dal pensar male. Dall’esame delle tavole dei progetti sia del Bianchi che del Laperuta e del De Simone si nota infatti che il grafico di sezione della chiesa riporta tale ipogeo e ciò sgombra l’idea che si tratti solo di fondamenta.
Dall’approfondimento della storia costruttiva dell’edificio sul quale c’è ampia bibliografia si rileva che si tratta di un ipogeo destinato, una volta completato nella decorazione, ad accogliere addirittura come arredo le tombe dei sovrani Borbone.
Una incredibile destinazione fino ad oggi a tutti ignota ( sopratutto ai Tiktoker che ricchi di ignorante arroganza, narrano della nostra città).
N.B. Presumibilmente nella sala circolare coperta a volta, sarebbe andato il sarcofago del sovrano che l’avrebbe inaugurata e intorno le tombe degli altri re della dinastia. Nell’anello circolare che gira intorno alla sala le tombe di tutti i principi reali.
La conferma dell’ipogeo quale pantheon dei Borbone si trova nel coevo volume del 1858 Storia dei Monumenti di Napoli dell’architetto Camillo Napoleone Sasso dove l’autore riporta la descrizione in dettaglio dell’edificio, una sorta di cronaca essendo egli un contemporaneo e conclude la descrizione con tale dichiarazione, di grande importanza, sfuggita fino ad oggi agli studiosi: «Evvi la chiesa sotterranea che risponde perfettamente al Tempio superiore. Questa è destinata ad accogliere le ceneri dei Reali di Napoli: essa s’innalza all’altezza di palmi 50, avendo nel centro una colonna di sostegno e base alle volte che formano la covertura del soccorpo, e il pavimento del descritto Tempio».
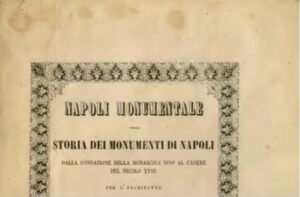
E anche il Chiarini nella sua guidaNotizie del Bello, dell’antico e del curioso, del 1858 con le aggiunte al Celano, conclude così la descrizione della Basilica : «…Sono non ultime cose da vedersi la Chiesa sotterranea che risponde perfettamente al tempio superiore. Destinata ad accogliere le ceneri de’ Reali di Napoli, essa s’innalza all’altezza di palmi cinquanta ed è sostenuta da una colonna che sorge nel centro».
Non solo, anche un autore coevo non napoletano, lo storico e geografo Eugenio Balbi in un volume, edito a Torino nel 1842 che raccoglie i suoi scritti pubblicati sui giornali dell’epoca, tra i quali uno dedicato alla chiesa di San Francesco di Paola, nel descrivere la maestosità della chiesa riporta quanto segue: «Il tempio cilindrico che abbiam veduto esser la parte centrale della basilica di S. Francesco di Paola, considerato relativamente alle sue dimensioni, vuol esser tenuto come la maggiore delle rotonde a nostri giorni erette.…..Ma lasciando stare questo argomento, nè toccando del tempio sotterraneo di egual dimensione del superiore, ad ampia vòlta sostenuta da una colonna centrale, ove riposeranno le salme mortali dei sovrani delle Due Sicilie, fino ad ora deposte in S. Chiara……
Perché poi le tombe dei sovrani non siano poi più state traslate nell’ipogeo della chiesa di San Francesco di Paola resta un mistero. Forse i sovrani di padre in figlio (da Ferdinando I che volle erigere la chiesa a Francesco I che non la vide ancora completata, a Ferdinando II che pare non volesse cambiare il luogo di sepoltura) ebbero ripetuti ripensamenti, dovuti al fatto che la chiesa di Santa Chiara era legata alla memoria storica della dinastia dei Borbone e fin dagli Angioini era sempre stata destinata ad accogliere le tombe dei sovrani del Regno di Napoli.
Un’ulteriore conferma deriva dal fatto che Ferdinando II tentò inutilmente a più riprese di ampliare lo spazio destinato alle tombe degli antenati nella cappella di San Tommaso apostolo della chiesa di Santa Chiara, affidandone il progetto prima nel 1845 all’architetto Genovese (quello dello scalone di Palazzo Reale), poi nel 1848 all’architetto Nicolini (quello della ricostruzione del San Carlo) e poi all’architetto Gavaudan nel 1859, ma dovette rinunciare per evitare di intervenire su strutture monumentali quali il Chiostro dei Minori che avrebbero subito danni e mutilazioni come anche la detta cappella dove tutt’oggi si conservano i resti dei Borbone. Di sicuro ciò che avvenne nel 1860 che cambiò la storia della nostra città e dell’Italia pose fine ad ogni ulteriore tentativo.
CURIOSITA’: Questo piccolo gioiello architettonico semisconosciuto ai napoletani , esiste da circa due secoli e rappresenta uno spazio sotterraneo della nostra città dove gli effetti sonori di rifrazione e di amplificazione del suono”, in maniera particolare si ripropongono anche negli spazi circostanti collegati alla sala centrale.
Immaginate ora per un solo momento questo incredibile spazio del sottosuolo di piazza del Plebiscito connesso con piccoli lavori al vicino spazio della Galleria Borbonica risalente al tempo di Ferdinando II di Borbone e pensate ad un ingresso da Piazza del Plebiscito e a una percorrenza fino a via Morelli.
Pensate che meraviglia ….un accesso alla Napoli sotterranea con uscita dall’altra parte della città”.
ARTICOLO DI COSE DI NAPOLI SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA