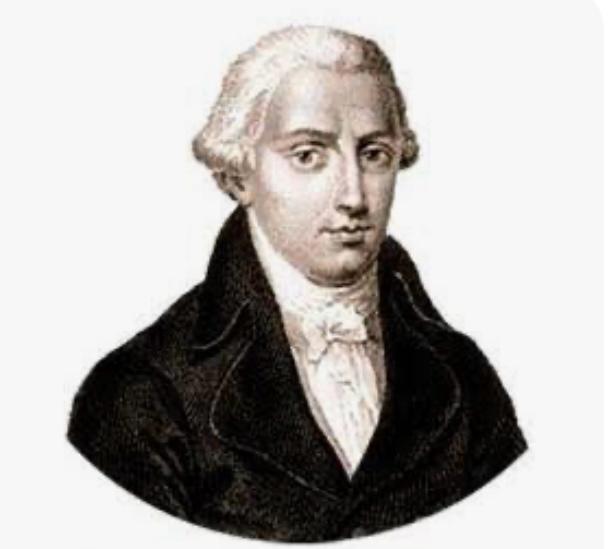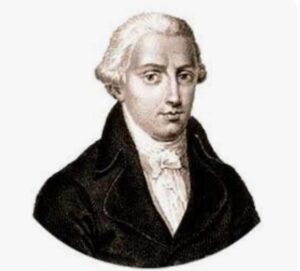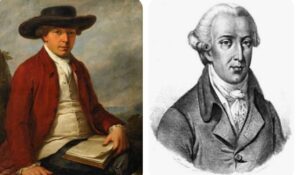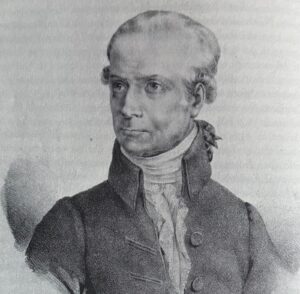![]()
Domenico Cirillo è stato uno di quegli uomini da annoverare tra i personaggi illustri della nostra città sempre feconda di ingegni eccellenti . Egli è stato non solo un grande uomo di scienza ma anche uno di quei medici capaci come pochi di dedicarsi con disinteresse agli ammalati .
Grazie al suo grande amore per l’arte medica e per il prossimo egli infatti correva più rapido ai tuguri dei poveri che ai palazzi dei ricchi, reputando che l’arte salutare dovesse esercitarsi a sollievo della miseria umanità, non come strumento per procacciarsi ricchezze.
Il suo disinteresse per il danaro da guadagnare con la professione medica era cosa singolare e rara. Chiamato da un ricco e da un povero, andava prima dal povero, e oltre a soccorrerlo amorosamente dell’arte sua, lo aiutava con propri denari a liberarsi dalla miseria.
Animato dal suo amore profondo per l’arte medica, egli si occupava in ugual misura sia di pazienti ricchi che poveri non mancando spesso di aiutare per pietà, sovente a discapito della sua borsa, i più indigenti .
Nato a Grumo Nevano l’11 aprile del 1739 in una famiglia che poteva vantare una lunga tradizione nella professione sanitaria e nelle discipline naturalistiche: egli era infatti il pronipote di Nicola Cirillo, filosofo cartesiano e medico di spicco nella Napoli del secolo precedente, dal quale eredita la propensione agli studi, la sensibilità nella cura dei malati e l’attenzione per i problemi della società.
Ad avviarlo nella formazione scolastica è lo zio Santo, cultore di disegno e di botanica, e possessore di un berbario (sul modello di quello di Ferrante Imperato) che il giovane Domenico arricchirà ulteriormente (in particolare dopo un viaggio in Sicilia nel 1764, dove raccolse un gran numero di piante rare).
N.B. Il precoce interesse per il mondo vegetale – che sarà la sua principale passione – si paleserà già con piccoli esperimenti e l’osservazione al microscopio della fecondazione delle piante affermando tra l’altro l’importanza del ricorso ai trattamenti naturali. Anni dopo, con la vittoria al concorso universitario, nel 1761 otterrà la cattedra di Botanica, incarico che manterrà sino al 1777.
Il suo primo filone di studio fu quello relativo alle arti sanitarie: a soli 16 anni, nel 1755, si iscrisse infatti alla facoltà di Medicina e Chirurgia, effetuando un percorso di studi che seguì con grande abnegazione sotto la guida di un luminare: Francesco Serao (peraltro allievo del prozio Nicola Cirillo) laureandosi quattro anni dopo.
A soli ventisette anni ottenne la cattedra di Patologia Medica, e successivamente quella di Botanica, distinguendosi per il rigore scientifico e l’attenzione alla dimensione umana della cura.
Sostenuto dalla sua grande passione per la medicina ed il profondo interesse per la botanica, la filosofia naturale e il progresso civile , il nostro Cirillo, fu uno dei primi medici napoletani a concepire la medicina come disciplina fondata sull’osservazione diretta e sull’esperienza clinica, liberandola dalle superstizioni e dagli schemi dogmatici. I suoi studi di botanica lo portarono a esplorare la flora del Regno di Napoli, introducendo un metodo sistematico che si rifaceva ai modelli linneani. Fondò un giardino botanico privato e pubblicò lavori che gli valsero riconoscimenti internazionali: fu membro della Royal Society di Londra, della Società Linneana e di altre accademie europee.
Aperto, come tutte le persone intelligenti, alle novità, Cirillo approfittò della presenza a Napoli di un medico cinese per apprendere i segreti di un metodo terapeutico noto in Estremo Oriente ma pressoché sconosciuto in Occidente: la “sfigmica”, ovvero la cosiddetta “ scienza del polso”. Un’esperienza che lo spingerà a praticare e a promuovere sempre di più l’osservazione clinica, introducendo nell amedicina classica l’uso dell’olio di ricino e del tartaro ematico, l’uso di pomate e polveri antifebbrili e la promozione dell’innesto del vaiolo combattuto dalla Curia romana, e con essa salvò la vita di Filippo Marini marchese di Genzano, spento sul patibolo nel 1799 il quale morì baciando il carnefice.
ll suo innegabile talento , i suoi studi scientifici ed il grande amore mostrato verso gli ammalati per quali tutto lasciava da parte quando si trattava di salvarli da una grave malattia, egli con il suo costante si impegnò molto in ospedali e in carceri nell’intento di migliorare le stanze dei malati di corpo e spirito,
Questo lo portò con una una rapida carriera ad ottenre nel 1774 la prestigiosa cattedra di Medicina teorica e poi di Medicina pratica (che terrà sino alla morte) . Venne poi nominato docente di Fisiologia e Ostetricia (succedendo al professor Orazio Biancardi), agli “Incurabili”, un ospedale che diventerà la sua casa.
Nel campo dell’Ostetricia formò presso l’ospedale degli Incurabili allievi come Bruno Amantea e Angelo Leonessa collaborando con maestri come Domenico Cotugno e Antonio Sementini dello stesso nosocomio con i quali diede inizio per il trattamento esterno della lue l’uso de bicloruro di mercurio.
Fu inoltre il primo ad aprire le porte a quest’ insegnamento vincendo così i vecchi retaggi che avevano lasciato questa specializzazione all’attività delle levatrici.
Il Cirillo compose nella sua splendida carriera nove opere di botanica, dieci di materia medica, e vari discorsi accademici, che furono scritti in latino e in volgare.
Collaborò con i maggiori medici e scienziati dell’epoca come il grande anatomista e ostetrico scozzese William Hunter (dal quale apprese il metodo di iniezione nei vasi linfatici), frequentò le più importanti accademie europeee intrecciò un saldo legame di stima e amicizia con Benjamin Franklin.
Fu nominato direttore del Museo di Scienze Naturali e segnalato al re come candidato ideale (e unico) per dirigere l’Orto Botanico che si voleva creare (progetto che verrà realizzato anni dopo).
La sua casa a Pontenuovo, divenne un luogo dove tutti coloro che si interessavano a Napoli di scienze, medicina e botanica si rivolgevano per uno spassionato consiglio . Dotto e amabile per suoi modi gentili, era carissimo a tutti i buoni e sapienti, e quando lo colse una grave malattia, la città ne fu addolorata, come un pubblico danno. Il Cirillo comunque non fu solamente un medico e botanico, ma anche un letterato ed un grande amico di letterati.
Alla sua intensa attività universitaria. ai suoi numerosi libri scritti e tradotti in varie lingue, e alla frequentazione delle più importanti accademie europee, oltre naturalmente alle fattive collaborazioni con i maggiori medici e scienziati, egli non lesinava mai di affrontare la sua attività medica nei confronti del paziente con umanità e carità cercando di sollevare e aiutare le persone più povere dalle loro miserie, fame, nudità, freddo e malattie dedicando loro tempo e cure che divennero lo strumento dell’altrui felicità, che lo caratterizzarono.
CURIOSITA’: Principi che come vedete ribadiscono la forza di quell’impulso che muoveva l’intellettuale napoletano nella direzione della lotta alla ignoranza, in favore della giustizia sociale, del progresso civile, dell’evoluzione (anche quella interiore) dell’essere umano. Un orizzonte di pensiero che spiega facilmente la sua adesione ai principi della rivoluzione giacobina, il grande sogno di libertà, fraternità e di uguaglianza che stava sconvolgendo mezza Europa, un’utopia destinata a restare tale.
Il suo prestigio scientifico e la sua grandezza di medico oramai riconosciuta, gli fece guadagnare la stima della regina, la quale si affidò senza indugi alle sue cure e lo vorrà nel suo staff sanitario ( una considerazione che Maria Carolina d’Austria purtroppo dimenticherà insieme a tante altre cose alcuni anni dopo ).
Fu nominato quindi medico personale della regina Maria Carolina d’Austria, moglie di Ferdinando IV, che ammirava la sua competenza e la sua onestà intellettuale. Alla corte borbonica, in quegli anni Cirillo si mosse con equilibrio in quel difficile ambiente politico : uomo di scienza più che di potere, evitò le adulazioni e mantenne una condotta improntata alla dignità e alla sobrietà. La regina, influenzata da idee illuministe, si circondava di intellettuali e riformatori, e per un periodo il medico godette della sua fiducia e del suo rispetto.
Tuttavia, con il volgere degli eventi e il precipitare della crisi rivoluzionaria, quell’equilibrio si spezzò. Quando nel 1799 venne proclamata la Repubblica Napoletana, Cirillo dopo un precedente rifiuto fatto al generale Jean Antoine Championnet di presiedere al nuovo governo cittadino, accettò un secondo invito del nuovo governo come presidente della Commissione legislativa lavorando a stretto gomito insieme al giurista Mario Pagano e altri personaggi di spessore, con spirito principalmente umanitario.
CURIOSITA’: Avvenuta la rivoluzione del 1799, i nuovi repubblicani con voti unanimi lo chiamarono a governare me egli sulle prime, e per modestia e per amore all’arte sua, ricusò; ma chiamato una seconda volta dal voto pubblico, quando la patria era in pericolo, accettò l’onore di essere rappresentante del popolo, e fu presidente del corpo legislativo.
La città di Napoli in quel periodo versava in grave miseria economica. Vi era scarso cibo, mentre le casse vuote dell’erario, erano vuote grazie ai cessati guadagni fatti per la guerra. Era quindi cresciuto a dismisura nella immensa città il numero dei poveri. Primo pensiero dell’uomo virtuoso di soccorrere la pubblica miseria, contro la quale tutti i mezzi indicati dall’ingegno erano manchevoli.
Cirillo, pubblicato il suo Progetto di carità cittadina, stabilì una cassa di soccorso, e cominciò col mettervi tutte le ricchezze che aveva guadagnate coll’esercizio della sua professione.
L’atto generoso eccitò ad imitazione tutte le persone più virtuose, le quali, oltre a offrire quanto era, in loro facoltà, si recavano per le case a chiedere soccorsi.
In ogni contrada furono eletti un cittadino ed una donna che godessero la pubblica stima: fu dato il nome onorevole di padri e madri dei poveri, coll’incarico di visitare ogni giorno le case dei più miserabili, e di portavi il pane e i soccorsi che mandava la patria.
Soccorrevano gli ammalati con medici e medicine; procuravano anche lavoro a chi ne era privo; e così restituivano alla vita una turba grande di sventurati morenti di fame. La cassa di soccorso, sostenuta dalla carità cittadina, fece tutto quello che era possibile in questi momenti difficilissimi.
Domenico Cirillo fece anche di più propose che i legislatori e tutti impiegati rilasciassero una parte del loro stipendio a vantaggio degli infelici, e si rinunziasse al lusso delle vesti insultante la miseria del popolo.
Tutti riposero generosamente all’appello, e in tal modo fu posto riparo ai più urgenti bisogni, e se questi atti poterono salvare l’infelice Repubblica, mostrarono almeno che i reggitori di essa e gli amanti degli ordini nuovi uomini virtuosi e degnissimi di viver liberi.
N.B. In realtà ncome vedete . non si può parlare di Cirillo politico: egli non fu altro che un uomo giusto, colto e probo prestato alla politica in nome di un ideale di giustizia ed eguaglianza. Il medico di Corte che, sempre pronto a chinarsi sugli ammalati più indigenti, conosceva le miserie fisiche e morali delle classi meno abbienti che trovarono negli ideali della Repubblica una risposta alle proprie speranze.
Nel suo ruolo amministrativo-istituzionale, mostrando coerenza e coraggio, Cirillo firmò alcune leggi come quella che istituiva un Fondo di assistenza popolare (“Cassa di soccorso e carità”) nella quale peraltro versò tutti i suoi beni, o la legge che aboliva la tassa sul pesce, ma anche l’ordine di sequestro delle proprietà dei Borbone; inoltre prese posizione per migliorare la condizione dei carcerati, un indirizzo che sarà in seguito raccolto da Giuseppe Bonaparte, che nel 1806 varerà una riforma finalizzata a riportare una quota di umanità e di igiene nelle prigioni in linea con gli standard degli altri Paesi.’
CURIOSITA’. Domenico Cirillo non fu uomo d’armi né di partito, ma di principi: credeva nella libertà, nell’uguaglianza civile e nella responsabilità morale degli intellettuali. Nominato membro del governo provvisorio, si adoperò soprattutto in campo sanitario, cercando di mitigare le conseguenze sociali dei conflitti e delle epidemie.
Dopo la tragica caduta della Repubblica napoletana e la restaurazione borbonica, gli fu offerta la possibilità di fuggire o di ottenere clemenza attraverso l’intercessione della stessa regina, che un tempo aveva curato. Cirillo rifiutò di chiedere grazia, dichiarando di non poter rinnegare ciò in cui credeva. Arrestato fu inizialmente rinchiuso prima nella stiva del vascello da guerra “ San Sebastian” e poi trasferito nella tristemente nota “fossa del coccodrillo”, nelle terrificanti carceri sotterranee di Castel Nuovo.
N.B. Anche Domenico Crillo era stato vittima del tradimento del patto stretto tra il comandante delle truppe borboniche e i repubblicani con il quale il cardinale Fabrizio Ruffo aveva firmato una “onorevole capitolazione” che concedeva agli sconfitti di potersi imbarcare per la Francia, ma Ferdinando IV e soprattutto la regina (il vero sovrano), forti dell’appoggio inglese, non avevano tenuto fede all’impegno preso e avevano fatto arrestare tutti per dare inizio alla triste carneficina.
L’ormai sessantenne medico e scienziato di fama mondiale fu tenuto in una caverna-prigione per ben quattro mesi dove c’erano altri diciotto sventurati, fra cui Pagano, Albanese, Logoteta, Baffi e Rotondo (Giuseppe Albanese, fautore della Repubblica fu giustiziato il ventotto novembre del 1799.
Curiosita’: Si raccconta che giudice Speciale, che emise la condanna di morte e cge aveva dei modi plebei e parolemolto volgari , con l’idea di avvilire i prigionieri, ad un certo punto domandòa Cirillo : “È in faccia a me, chi sei tu?” E Cirillo: “E in faccia a te, codardo, sono un eroe”. Interrogato sopra altri capi di accusa, rispose: “Ho capitolato colle prime potenze d’Europa: se il diritto delle genti è rispetto, nulla vi è da rispondere, e voi non dovete fare altro che eseguire il trattato; ma se si vuole violare i primi doveri della società, i miei carnefici possono condurmi al supplizio, che non ho nulla da rispondere” e dopo queste parole si mantenne sempre in silenzio e il tribunale scrisse la sua sentenza di morte. Tutti rimasero ammirati di questa eroica fermezza, egli domandò solamente la grazia di morire con i suoi amici più cari e la domanda gli fu concessa.
Con il ritorno a Napoli di Ferdinando IV, Cirillo venne quindi condannato a morte e il 29 ottobre 1799, in piazza Mercato, per morire impiccato, poiché non apparteneva alla nobiltà.
N.B. I condannati aristocratici furono invece decapitati con la ghigliottina: una distinzione crudele che testimoniava la persistenza delle disuguaglianze sociali che egli aveva voluto combattere.
Quella triste mattina del 29 ottobre del 1799 Cirillo fu condotto al patibolo in piazza Mercato, dove venne ucciso assieme a Mario Pagano, Ignazio Ciaia, Vincenzo Russo e al suo caro amico Nicola Pacifico, i cui resti saranno poi gettati alla rinfusa nell’ipogeo della vicina chiesa del Carmine. L’esecuzione la morte del grande medico, suscitò grande pietà anche tra i suoi avversari e servì alla fine solo a far crescere ulteriormente l’ondata d’indignazione che stava attraversando tutta l’Europa e farà cadere ancora più in basso il giudizio sulla Corte napoletana, peraltro già da molto tempo discreditata se non apertamente disprezzata.
N.B. Tutte vittime dello sterminio che privò Napoli di molte delle sue menti migliori, provocò un trauma che non si sarebbe più sanato, una ferita per certi versi ancora aperta, e impresse sulla dinastia borbonica una macchia storica indelebile, un marchio d’infamia.
Il giorno stesso fu dato ordine alla plebaglia sanfedista di saccheggiare sia la casa sia lo studio del grande medico e tutto fu distrutto o dato alle fiamme: andò così perduto per sempre un patrimonio inestimabile: la ricchissima biblioteca, le eccezionali collezioni botaniche e zoologiche, i manoscritti di Nicola Cirillo (con un gran numero di lettere scritte da Isaac
Newton) e diverse opere inedite.
Le sue ossa sono quasi certamente lì dove furono gettate il 29 ottobre 1799, subito dopo l’esecuzione. Quel che resta dell’insigne medico, botanico ed entomologo napoletano Domenico Cirillo giace ancora oggi nel fango sotto la basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore assieme alle spoglie di altri grandi uomini come Mario Pagano, Ignazio Ciaia, Vincenzo Russo, ma anche Ettore Carafa, Giorgio Pignatelli e la povera Luisa Sanfelice, sulla quale il boia si accanì particolarmente per la gioia della folla assetata di sangue che si accalcava in piazza Mercato.
A far ancora peggio dei borbone che pure si accanirono vergognosamente affinché su quel battaglione di giovani eroi cadesse una vera e propria damnatio memoriae, ci sono riusciti solo i vari enti municipali che si sono succeduti negli ultimi duecento anni : a distanza di oltre due secoli le spoglie di Cirillo e degli altri martiri del 1799 infatti ancora abbandonate nell’oscuro sacrario, consumate dagli elementi e dall’oblio, ben celate a tutti quei napoletani che dovrebbero frequentemente ricordare il sacrificio di medici, giuristi, letterati, vescovi, giornalisti, sacerdoti, ingegneri, professori, scrittori, editori e altri uomini di scienza e di cultura per quel sogno di libertà, di giustizia, di eguaglianza, di civiltà infrantosi sulla forca, sotto la ghigliottina e nel cannibalismo della plebe.
Come infatti tutti certamente sanno , la sterminata folla che seguiva le esecuzioni con eccitazione bestiale si accaniva sui corpi delle vittime dopo l’esecuzione, facendoli letteralmente a pezzi, e i brandelli di organi venivano poi mangiati. Per frenare la ferinità del popolino (peraltro già emersa in altre occasioni) i Frati dei Bianchi della Giustizia scrissero più volte al re, supplicandolo di impedire che i cadaveri restassero sul patibolo senza protezione.
 In attesa che magari qualche amministratore pubblico degno di questo nome si prenda la briga di restituire a quei protagonisti della storia di Napoli il posto che meritano e che, in parte, gli hanno già restituito gli storici, e i loro resti trovino finalmente il giusto spazio in un adeguato pantheon cittadino, oggi non rimane altro che ricordare Domenico Cirillo , come uno dei più illustri scienziati e martiri dell’Illuminismo napoletano. In lui la scienza e la coscienza civile si unirono in modo indissolubile. Fu un uomo di ragione e di alto significato morale poiche difese la sua scelta di restare fedele alla verità, anche quando la verità conduce al sacrificio.
In attesa che magari qualche amministratore pubblico degno di questo nome si prenda la briga di restituire a quei protagonisti della storia di Napoli il posto che meritano e che, in parte, gli hanno già restituito gli storici, e i loro resti trovino finalmente il giusto spazio in un adeguato pantheon cittadino, oggi non rimane altro che ricordare Domenico Cirillo , come uno dei più illustri scienziati e martiri dell’Illuminismo napoletano. In lui la scienza e la coscienza civile si unirono in modo indissolubile. Fu un uomo di ragione e di alto significato morale poiche difese la sua scelta di restare fedele alla verità, anche quando la verità conduce al sacrificio.
Del grande uomo , medico e botanico oggi resta nella nostra città solo quel busto conservato nel Museo delle arti sanitarie di Napoli (a pochi passi da quello di Ferdinando IV) e soprattutto il bel ritratto realizzato da Angelica Kauffmann tra il 1782 e il 1784 e custodito nel Museo di San Martino di Napoli, nel quale la pittrice svizzera ha fissato i tratti salienti di uomo che seppe essere umile nella sua oggettiva superiorità e fin troppo grande nella scelta di stare sino alla fine dalla parte degli ultimi. Quella stessa plebe che avrebbe poi festeggiato la sua morte con canti e balli.