![]()
Roberto d’Angiò aveva ereditato nel 1309 il trono di Napoli dal padre Carlo II e subito, contrastando la venuta dell’imperatore Enrico VII, era diventato il leader del guelfismo italiano
Soprannominato “il saggio “Roberto, fu un grande mecenate ed un uomo di grande cultura; le sue corti furono frequentate dai grandi intellettuali del tempo e la stessa città durante il suo regno guadagnò un conseguente prestigio.Nella sua corte regale egli possedeva una notevole biblioteca gestita dall’erudito Paolo da Perugia.
Colto e mecenate, ospitò a corte tra i numerosi letterati del tempo anche il giovane Giovanni Boccaccio nei primi passi della sua carriera letteraria. Petrarca vista la sua cescente fama di letterato e umanista lo conobbe all’inizio del 1341, quando dimorò circa un mese a Napoli per essere esaminato prima dell’incoronazione poetica . Il re , da grande uomo di cultura, in questo mese , dopo aver valutato la sua preparazione umanistica e poetica, lo incoronò l’otto aprile 1341, nel giorno di Pasqua , nella città di Roma in un rituale con l’alloro sul Campidoglio ispirato a rituali del mondo romano.
N.B. Questo rito consistente nell’usanza di cingere con uanaghirlanda di alloro la fronte dei poeti era derivato dagli antichi greci che in questo modo pintendevano celebrare e onorare pubblicamente poeti considerati di grande valore. : fu da essi, infatti, che i Romani la appresero, ma dalla fine dell’età imperiale essa era divenuta desueta.
Nel settembre 1340, Francesco Petrarca ricevette contemporaneamente, due missive, una dal cancelliere dell’Università di Parigi e l’altra dal Senato Romano, che lo invitavano a ricevere la corona d’alloro, la stessa che aveva già circondato la fronte di Virgilio e che persino Dante Alighieri aveva sperato invano di avere.
Il poeta , ovviamente optò per Roma affermando che a Roma ci fosse la parte più grande della sua ricchezza spirituale. Per raggiungere l’Urbe, il poeta volle seguire la più tradizionale delle vie e scelse come giudice, esaminatore ,un sovrano illuminato e dotto che nella sua bella reggia affacciata sul mare era solito accogliere alla sua corte poeti e filosofi, letterati ed artisti.
Si imbarcò quindi per Napoli,e dopo un viaggio durato un mese intero,finalmente raggiunse la sede di Roberto d’Angiò (il maschio Angiono )uomo colto, amante delle arti e autore di molti trattati, il quale per tre giorni consecutivi, dal mattino alla sera, lo sottopose agli esami di rito, nella sala maggiore che era la piu’ grande e nobile del castello con una volta alta 28 metri affrescata da Giotto. Petrarca,Il re saggio e potente sostenne gli esami del Petrarca, emozionato come una matricola di frinte al re saggio superò brillantemente gli esami , ma solo il quarto giorno il sovrano, finalmente convinto che il Petrarca fosse degno di onore gli concesse a pieni voti la licentia che gli permetteva di sostenere l’esame pubblico dinanzi ai docenti dello Studio napoletano, il cosiddetto conventus. Superata anche quest’ultima prova,il Petrarca era finalmente pronto per essere incoronato poeta sarebbe poi divenuto uno dei piu’ grandi letterati di tutti i tempi).
I ricordi delle conversazioni avute con il re prima dell’esame vero e proprio disegnano il prototipo del perfetto sovrano, saggio e virtuoso oltre che esperto politico, e tale è la raffigurazione di lui che ritorna costantemente nelle opere petrarchesche (per esempio nei Rereum memorandarum libri e nel Trionfo della fama ) ; dietro sua richiesta, inoltre, Petrarca gli dedicò l’Africa . Fece però in tempo a indirizzargli solo tre lettere, dato che Roberto morì poco dopo, all’inizio del 1343; in seguito alla sua scomparsa il regno precipitò in una profonda crisi, come Petrarca poté constatare quello stesso anno nel suo secondo e ultimo soggiorno napoletano e come raccontò allegoricamente nell’egloga II del Bucolicum carmen In memoria del defunto compose anche un epitaffio laudativo.
Due anni dopo, sul finire del 1343, il poeta era a Napoli per compiere un’importante ambasceria e in città gli capitarono cose notevoli e, diremmo, spaventevoli. Sono due episodi, non noti a tutti, narrati nelle Lettere familiari, in particolare nella Epistola al cardinale Giovanni Colonna riportata nel libro V, lettere 5 e 6..
Cosa era successo di tanto terribile? Ripercorriamo insieme quegli avvenimenti sulla scorta delle parole del poeta il quale ne uscirà sconvolto.
Come antefatto, dobbiamo prima di continuare dobbiamo ricordarvi che l’anno 1343 fu un anno di grande lutto a Npoli : era morto, infatti, proprio Roberto d’Angiò re amatissimo dal poeta, soprannominato il Saggio. La dinastia angioina, però, non poteva permettersi un vuoto dinastico, pertanto il poeta ricevette un’importante ambasceria da parte di papa Clemente VI e del cardinale Giovanni Colonna di Stigliano . Il suo compito era ratificare la scelta dinastica del defunto Roberto che ricadeva sulla sedicenne Giovanna, la futura e famosa Giovanna I d’Angiò promessa sposa dell’altrettanto giovane Andrea d’Ungheria .
Ma dovete anche sapere che la nostra città all’epoca degli Angioini, aveva una configurazione assai diversa da quella attuale. Soprattutto era più piccola, e tante zone oggi normalmente incluse entro il circuito urbano un tempo erano al di fuori della città, confinando con orti e campagne. È il caso della odierna Via Carbonara , un tempo zona periferica in cui si gettavano i rifiuti fuori della città, un posto maleodorante e pericoloso. Essa si trovava nell’area del cosiddetto Campus Neapolis, tra porta san Gennaro allora esistente e porta Capuana ancora da erigersi.
Esso, era anche il luogo in cui in epoca angioina si tenevano cruenti combattimenti tra uomini che si sfidavano ad armi bianche fino all’ultimo sangue. I combattimenti si svolgevano secondo il modello degli antichi giuochi dei gladiatori , ed al cospetto spesso, si dice, della giovanissima regina Giovanna e di suo marito Andrea d’Ungheria. Erano questi spettacoli sanguinosi e mortali che spesso finivano in modo macabro. I lottatori combattevano infatti con le loro armi bianche fino a quando uno dei due non moriva e non era raro vedere uno di loro soccombere perchè sgozzato da un pugnale o morire sanguinante con le budelle totalmente esposte.
N,B, Per interrompere i feroci combattimenti dovette addirittura intervenire con una bolla Papa Giovanni XXII. Egli nel tentativo di fermare quell’orrendo spettacolo, aveva vietato con una bolla quei terribili giochi, pena la scomunica per lottatori e spettatori, ma nonostante tutto i giochi erano continuati e così, per non far brutta figura, su proposta dell’Arcivescovo di Napoli, il successore Papa Benedetto XII levò le scomuniche già nominate e sospese la proibizione dei giochi.
Questi furono poi banditi con successo solo mezzo secolo più tardi col re Carlo di Durazzo. I giochi venivano chiamati \” gioco della Carbonara \” e questa potrebbe anche essere una delle ipotesi sulle origini del suo strano nome.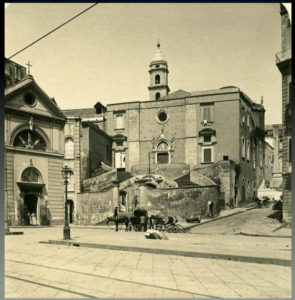
Al raccapristante spettacolo di questi “giochi”, pensando di fare cosa gradita venne portato nell’autunno del 1343 anche il Petrarca che soggirnava a Napoli da pochi mesi
Il poeta come un semplice turista si era lasciato trasportare prorpio in quella zona perifercica della città chiamata Carbonara . Nessuno gli aveva detto che questa era una zona periferica della città e poco controllata dal governo centrale .E nessuno sopratutto lo aveva avvertito che in questo luogo si radunavano in genere tutti i gaglioffi ed i delinquenti di Napoli e provincia che spesso sfidavano tra di loro a duello, risolvendo in questo modo i problemi di debiti, rivalità d’amore o particolari offese.
Gli aveveno solo detto che lo portavano ad assistere ad un gioco di gladiatori , senza per nulla accennare che quello era uno dei giochi più violenti che si svolgevano allora in città.
Ma qualcosa andò storto …
Lo spettacolo venne annunciato da un fragoroso applauso che nella sua evoluzione sciocco non poco il poeta :
“A tanto concorso di gente, e a tanta attenzione d’illustri personaggi sospeso, fiso io guardava aspettando di vedere qualche gran cosa, quand’ecco come per lietissimo evento un indicibile universale applauso s’alza alle stelle. Mi guardo intorno e veggo un bellissimo garzone trapassato da freddo pugnale cadermi ai piedi. Rimasi attonito, inorridito” (Lettere familiari, libro V, lett. 6: Epistola al cardinale Giovanni Colonna).
Il poeta nel vedere quello che veniva considerato all’epoca , uno dei giochi più cruenti del tempo rimase scioccato a tal punto da scivere subito dopo più una lettera al suo corrispondente cardinale Giovanni Colonna al quale doveva rapportare tutto.
“In pieno giorno, alla vista del Popolo, al cospetto del Re, in questa città d’Italia con barbara ferocia, si esercita l’infame gioco dei Gladiatori; e come sangue di pecore, l’umano sangue si sparge, e, plaudendo l’insano volgo affollato, sotto gli occhi dei miseri genitori si scannano i figli” (Lettere familiari, libro V, lettera 6: Epistola al cardinale Giovanni Colonna).
Ma quello che più sorprese al poeta fu la partecipazione a quei violenti giochi anche dei due giovani reali Giovanna e Andrea che apparvero a lui i eccitati dalla violenza che si svolgeva nel loro futuro regno:
“Era presente la Regina, presente Andrea (d’Ungheria) re fanciullo, che di sé promette riuscir magnanimo, se pur riesca a porsi in capo la contrastata corona” (Lettere familiari, Epistola al cardinale Giovanni Colonna).
Il poeta è scioccato,, eppure non è nulla a confronto di ciò che gli accadrà di lì a poco, come narrato nella episole del 26 novembre 1343, dopo un tremendo tsunami che colpì in quel periodo la nostra città.
Questo fu uno degli episodi più terrificanti della storia partenopea,da annoverare a fianco alle terribili eruzioni che funestarono il regno di Napoli. Però, diversamente da queste, di cui ci restano testimonianze nei dipinti o nelle statue di san Gennaro in atto di bloccare la lava distruttrice, della terribile mareggiata del 1343 abbiamo meno fonti, se non quelle del Petrarca il quale allora poeta era ospite a Napoli dai frati nella chiesa di San Lorenzo Maggiore (la stessa chiesa che solo sette anni prima fu teatro dell’incontro di Giovanni Boccaccio con la sua amata Fiammetta) .
Il racconto dell’accaduto è infatti affidato alla lettera n. 5 del libro V delle Epistole familiari, indirizzata come sempre al cardinale Giovanni Colonna di Stigliano:
“Io ti vo far persuaso che nulla di così orribile, nulla di così furioso erami avvenuto di vedere giammai. Egli è meraviglioso a dirsi che già la fama dell’imminente flagello aveva annunziato: e certo Vescovo di un’isola di qui vicina il quale si diletta d’astrologia, or son pochi giorni lo aveva predetto. Conciossiaché però avvien di rado che le congetture colpiscan dirittamente nel vero, non una fortuna di mare, ma un terremoto, e la rovina di Napoli per lì 25 novembre del 1343 aveva minacciata.”
Ma andiamo con ordine.
Il Petrarca nel 1343,si trovava nella nostra citta’ per conto di Clemente VI, per perorare la causa di alcuni prigionieri ( tre cardinali cari al cardinale Colonna che erano rinchiusi nelle segrete di Castel Capuano condannati all’ergastolo). Nello svolgere questa delicata missione egli era momentaneamente ospite nel convento , dei frati francescani presso la Basilica di San Lorenzo.
Quella notte il poeta stava tranquillamente dormendo nel suo letto quando all’improvviso un boato e una scossa tremenda fece tutto il convento , il lume si spense e il poeta per istinto schizzò via dalle coperte:
“Io volli aspettare per vedere qual fosse il tramonto della luna, che era, se non m’inganno, nel suo settimo giorno. Stetti dunque alla finestra finché poco innanzi la mezza notte cinta da un nembo, e tutta meglio calarsi la vidi, ed occulta dietro il monte vicino; e talora entrai nella mia camera e così tardi mi posi in letto a dormire. Aveva appena preso sonno, quando con improvviso orrendo fragore non le sole finestre ma tutte le mura e la volta di solidissima pietra fabbricate dalle ime fondamenta tremando si scuotono: il lumino che, me dormente veglia la notte, si estingue: balzammo dai letti…”
Petrarca era scosso, spaventato. Cosa poteva mai essere quel tumulto che, sorgente dalle viscere della terra, faceva tremare tutto, non solo il convento ma anche l’intera città?
Lui ancora certo non lo sapeva ma in quel momento, quella notte , l’ autore del Canzoniere fu il testimone di una spaventosa tempesta ,un terribile maremoto che sconvolse Napoli nel 1343. Fu un fenomeno che oggi potremmo identificare come uno tsumani .
Quella notte su Napoli si abbattè un tremendo uragano accompagnato da un terremoto ed il poeta pensando di dover morire fu preso da un terribile spavento . Tra urla di terrore fu scaraventato a terra e piangendo e pregando , scansando i crolli , miracolato , riuscì a mettersi in salvo raggiungendo nel buio l’esterno del chiostro dove i frati cercarono riparo . Fu una notte infernale che il poeta temendo il peggio trascorse ad invocare in preghiera la misericordia di Dio nel chiostro del monastero di San Lorenzo, insieme ai frati.
Il giorno dopo,il poeta, passando dal religioso timore a un cavalleresco ardire, ma ancora attonito ed impaurito, si precipitò a cavallo alla marina di Napoli per capire cosa fosse accaduto e scoprì con orrore scene strazianti che lo avrebbero poi tormentato per tutto il resto della sua vita ( persone affogate o che stavano per affogarsi, alcuni con la testa e altri con la braccia rotte o altri addirittura con le visceri che uscivano dal ventre ).
Scopriì che la furia delle acque aveva travolto anche il molo angioino che era completamente distrutto , mentre un’intera ala di Castel Nuovo era franata … che diverse galee in mare erano andate disperse e che il borgo dei pescatori era stato spazzato via, lasciando sulla spiaggia un macabro spettacolo di morte : il lido era infatti pieno dei cadaveri dei marinai, gettati sulla rena e sugli scogli “quasi fossero molli uova”.
Il mare era ancora molto agitato con onde enormi che minacciavano la città . All’improvviso questa visione plumbea fu illuminata da un attimo di grazia: la diciassettenne regina Giovanna I d’Angiò, col suo corteo di ancelle, uscì dalla reggia per pregare la Vergine affinché stornasse la sciagura dalla città. Non solo la regina, ma tutti i napoletani al cui corteo si aggiunse il poeta:
“Mi rincorai allora alcun poco, e tutti insieme ne andammo alla Chiesa ove prostesi in mezzo a mille gemiti passammo quella notte, pensando che da un momento all’ altro tutti morti saremmo.”
Il poeta descrisse poi quella notte e quell’esperienza con toni drammatici in una sua lettera al suo interlocutore cardinale Colonna., dicendo che d’ora in avanti potrà assegnargli qualsivoglia compito o missione, purché sia via terra: “che tu quinci innanzi mai più non abbia a comandarmi di porre la vita mia in balia de’ venti, e de’ flutti…”. E, poco oltre, aggiungendo:
“Mandami dove t’aggrada: non temo il Sarmata armato d’ arco e di frode, non pavento agli ospiti crudelmente beffardo il Mauritano: per via di terra mi spingerò fin tra gl’Indi. Ma se tu volessi rimettermi in mare, perdonami, te Io confesso, non per lo spazio solo de’ saturnali di Decembre, ma per sempre e per l’anno intero la mia libertà vorrei rivendicare.”
Petrarca se ne fuggì da Napoli, inorridito per la sciagura che aveva avvolto la città, ringraziando Dio che comunque lo aveva salvato. Fatto sta che s’imbarcò per Livorno e se la squagliò in carrozza verso l’alta Italia.
CURIOSITA’: II 25 aprile del 1343 l’enorme mareggiata che avvenne nella nostra città, non solo colpì con le sue enormi onde Napoli ma anche Amalfi, Maiori e Minori. Un grande maremoto, dunque, che squassò il litorale medio campano. Il colpevole di tutto si elevava e si eleva tutt’ora sul fondo del mar Tirreno: è il vulcano Marsili, alto tremila metri e sprofondato a 450 metri sotto il livello del mare. Lungo settanta chilometri e largo trenta è il più vasto vulcano di tutta Europa. Fu questo mostro a esplodere il 25 novembre del 1343, causando un’enorme mareggiata che squassò Napoli .
ARTICOLO SCRITTO DA ANTONIO CIVETTA







