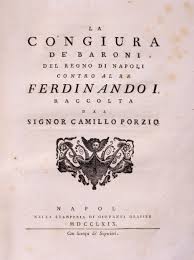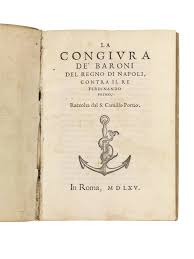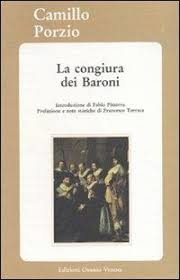![]()
Nel tardo XVI secolo, quando il luminoso bagliore del Rinascimento stava ormai sfumando, Camillo Porzio, giurista raffinato e storico appassionato, compose quello che resta uno dei più intriganti volumi dedicati al Mezzogiorno: La congiura dei Baroni.
Pubblicato nel 1565, riscosse un immediato successo, che venne ulteriormente esaltato nel periodo romantico, quando i nobili ribelli vennero idealicamente paragonati ai patrioti italiani in lotta per libertà e costituzione. Il libro narra in modo vivido la tragica vicenda dei nobili napoletani trucidati sotto Ferrante I d’Aragona, descritto con così brutale crudeltà che, nelle memorie successive, «fu dannata la sua memoria».
Camillo nacque a Napoli, in una splendida villa di Posillipo, in seno a una famiglia benestante che nutriva grande passione per le lettere e il diritto. Suo padre, il celebre Simone Porzio, sposato con la nobildonna Porzia d’Anna, era un uomo talmente stimato da essere definito, nel dialogo Della virtù di Torquato Tasso, «il miglior filosofo non solo di Napoli, ma dell’Italia tutta». Si racconta persino che egli padroneggiasse il greco al punto da coglierne tutte le sfumature aristoteliche.
Fu proprio Simone a occuparsi della formazione del figlio, indirizzandolo fin da giovane verso lo studio del diritto e della cultura classica. Oltre ad essere medico e docente di metafisica e filosofia presso l’Università di Napoli, Simone accettò nel 1545 l’invito di Cosimo de’ Medici – tramite il viceré don Pedro di Toledo – a tenere una cattedra a Pisa, trasferendosi così in Toscana.
Camillo, destinato agli studi giuridici, inizialmente frequentò l’Università di Bologna ma poi fu invitato dal padre a Pisa, dove strinse amicizia con lo storico Paolo Giovio. Fu proprio Giovio a suggerirgli di approfondire il tema della «Congiura dei Baroni». Completò così il suo percorso accademico e nel 1552 conseguì la laurea in utroque iure a Pisa, come attestato da un verbale conservato nell’Archivio di Stato di Firenze.
Simone, rientrato a Napoli per motivi di salute, ricevette da Cosimo de’ Medici notizia della laurea del figlio, ottenuta in via informale: rispose dunque tramite lettere al granduca ringraziandolo e chiedendo che si sollecitasse il ritorno di Camillo a Napoli, forse con l’intercessione della duchessa Eleonora di Toledo.
Tornato in patria, Camillo si trovò ad affrontare la gestione di un patrimonio ingente da dividere tra sei fratelli, e allo stesso tempo iniziò una promettente carriera di avvocato. Non riuscì però a consolidare l’amicizia con l’umanista Girolamo Seripando, augustiniano amico del padre, nominato arcivescovo di Salerno e poi inviato al Concilio di Trento come cardinale. Malgrado la distanza, Seripando continuò a consigliare e sostenere Camillo.
Quando fu in vendita un feudo nel Cilento, Centola, Seripando suggerì l’acquisto. Camillo lo acquistò dietro prestito e a nome del cognato Marino Russo – per 4760 ducati. L’operazione fu un successo, anche se per ragioni misteriose si procedette a intestarlo al cognato, scatenando una lunga lite legale tra gli eredi dello Russo e lo stesso Porzio.
Tra il 1560 e l’anno successivo, Camillo fu vittima di un episodio inquietante: qualcuno, presumibilmente un marito geloso, gli deturpò il volto, asportandogli parte del naso. Senza rivelare i dettagli, scrisse a Seripando di essersi rivolto a Tropea allo specialista Pietro Vianeo, abile nel ricostruire il naso: descriveva l’intervento e le sue sofferenze con crudezza. Solo in seguito si seppe che una donna sposata, da cui aveva avuto una figlia di nome Fulvia, era coinvolta nell’accaduto; il marito, Decio Scondito, sarebbe stato il responsabile. Alla morte di lui, Camillo sposò la sua amata.
Camillo perseguì ruoli pubblici retribuiti anche grazie all’influenza di Cosimo de’ Medici. Quando si liberò la carica di consigliere della città di Napoli, si fece avanti utilizzando la protezione del suo protettore toscano. Non sappiamo con certezza il risultato, ma Porzio era abilissimo nel tessere relazioni. Frequentava noblesse, avvocati, magistrati e storici come Antonio D’Afeltro, Scipione Bolvito e Angelo Di Costanzo, autore della Storia del regno di Napoli.
Tuttavia, la sua fama è soprattutto legata a La congiura dei Baroni, pubblicata nel 1565 da Paolo Manunzio a Roma. L’opera trasse forma dal suggerimento di Giovio e dai verbali processuali relativi alla congiura contro Ferdinando I, nei quali il conte Antonello Petrucci era coinvolto. Consigliato da Seripando a scrivere in italiano (“toscanamente”), Porzio volle rendere la storia accessibile e vivida, con uno stile narrativo intenso, quasi romanzesco.
Il successo fu immediato: le copie andarono a ruba. Dopo una pausa editoriale di circa cinquant’anni, il libro fu tradotto in francese a Parigi; nel XVIII secolo uscì in due nuove edizioni, e nel secolo successivo raggiunse una tiratura massiccia, consacrandolo come uno dei migliori testi del Cinquecento.
Camillo Porzio morì a Napoli nel 1580. Visse una vita intensa di passione per la storia e l’elegante stile del suo testo, come ristampato da Alessandro Cutolo nel 1982 in italiano moderno, continua a esercitare fascino per la sua vivacità e raffinatezza letterari.